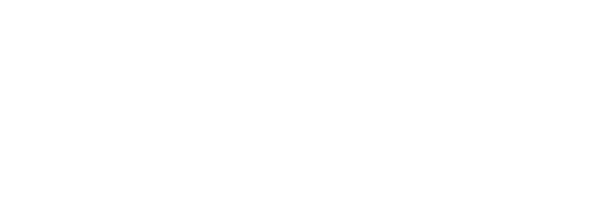Diritto alla salute
- Introduzione
- Le fonti normative
- Il diritto alla salute dei cittadini italiani senza dimora
- Il diritto alla salute dei cittadini stranieri senza dimora
- Le normative regionali
- Giurisprudenza
- Dottrina
- Approfondimenti
Il diritto alla salute costituisce parte integrante dei diritti umani fondamentali internazionalmente riconosciuti; infatti è concepito come il diritto di ogni persona a godere delle migliori condizioni di salute fisica e mentale che sia in grado di conseguire.
Tale diritto è stato menzionato per la prima volta nel 1946 nella Costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il cui Preambolo ha definito la salute come “uno stato complessivo di benessere fisico, mentale e sociale e non la mera assenza di malattie o infermità”, e ha ribadito che “il godimento delle migliori condizioni di salute fisica e mentale è uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano senza distinzione di razza, religione, opinione politica, condizione economica o sociale”. Il concetto di salute, quindi, esprime una condizione di complessivo benessere. Si tratta, quindi, di un diritto che sottende numerosi altri diritti socioeconomici, tra cui ad esempio l’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienici adeguati e il diritto a condizioni di lavoro sane e ottimali.
La salute è, inoltre, un diritto poliedrico per le innumerevoli situazioni soggettive ad esso correlate. Tra le altre, la più importante è sicuramente la tutela dell’integrità psico-fisica.
Le fonti internazionali che tutelano il diritto alla salute sono:
- l’art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948;
- la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) del 1950. Seppur il diritto alla salute non trovi espresso riconoscimento nella CEDU, la Corte di Strasburgo, istituita dalla stessa CEDU, ha progressivamente esteso la tutela convenzionale anche a questo diritto, tramite una interpretazione evolutiva ed estensiva di altre disposizioni della CEDU, come l’art. 3 della stessa (per approfondire il tema CEDU e diritto alla salute in carcere è possibile consultare questa pagina);
- l’art. 11 della Carta Sociale Europea del 1961;
- l’art. 12 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966.
Inoltre, il diritto alla salute è riconosciuto e tutelato anche all’interno dell’Unione Europea dall’art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2000 (Carta di Nizza).
A livello nazionale, l’Italia riconosce e tutela il diritto alla salute all’art. 32 della Costituzione ed anche tramite la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 relativa “Istituzione del servizio sanitario nazionale” (SSN).
Secondo la previsione Costituzionale: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
Da ciò derivano precise conseguenze giuridiche: il diritto alla salute è inalienabile, intrasmissibile, indisponibile e irrinunciabile; è un diritto valevole non solo per i cittadini italiani ma anche per gli stranieri. Lo Stato deve assicurare a chiunque l’accesso alle “cure”. Prestazioni che, a seconda dell’opzione legislativa, possono essere gratuite, compartecipate o a carico del destinatario.
A causa della crisi economica e sociale dovuta alla pandemia da COVID-19, è aumentato il numero di persone che vivono in povertà e che, non potendo più pagare un affitto o un mutuo per un alloggio, finiscono in strada. Perdere la casa vuol dire, prima o dopo, perdere anche la residenza.
Ma perché la residenza è importante? Secondo quanto previsto dalla legge n. 1228 del 24 dicembre 1954, è importante avere una residenza anagrafica perché la stessa è correlata a una serie di diritti fondamentali, come il diritto alla salute, al lavoro, al Welfare e al voto. La suddetta legge riconosce la residenza anagrafica o l’iscrizione all’anagrafe comunale come diritto soggettivo a tutti i cittadini, tranne agli stranieri non regolarmente soggiornanti sul territorio italiano. Ogni Comune, per il tramite del proprio Ufficio Anagrafe, in qualità di ufficiale del Governo, tiene il Registro delle posizioni dei singoli, delle famiglie e delle convivenze e registra le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio.
La residenza è stata riconosciuta come diritto soggettivo dagli artt. 2, 3 e 14 della nostra Carta costituzionale, dalla Sentenza n. 5463 1° dicembre 2003 della Sezione III del T.A.R. Lombardia, dagli artt. 43 ss. del Codice civile, dal D.P.R. n. 223 del 1989, dalle sentenze della Corte di Cassazione (la n. 499 del 2000 delle Sezioni Unite Civili, la n. 1738 del 14 marzo 1986, la n. 126 del 1972, la n. 4525 del 6 luglio 1983, la n. 1081 del 1968). Per completezza si segnala anche che il D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989, è stato modificato dal D.P.R. n. 126 del 17 luglio 2015.
La residenza anagrafica, o più precisamente l’iscrizione nell’Anagrafe del Comune (comma 1, art. 2 legge n.1228/1954), oltre ad essere un diritto, è un dovere per tutti i cittadini e l’Ufficiale dell’anagrafe attraverso propri poteri d’ufficio è tenuto a farlo rispettare (art. 15 Regolamento anagrafico approvato con DPR n. 223 del 1989 e art. 5 della legge n. 1228 del 1954). Ai sensi dell’art. 117 della Costituzione italiana e dell’art. 14 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico degli Enti Locali), ai Comuni è affidata la funzione amministrativa concernente le anagrafi, per esigenze nazionali statistiche, di controllo ed amministrazione della popolazione.
La legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Sistema Sanitario Nazionale (SSN), stabilisce che la prestazione sanitaria è legata alla residenza anagrafica e, dunque, le persone senza fissa dimora, non possedendola, non accedono al SSN, e hanno diritto solo a prestazioni di emergenza presso i pronto soccorso. Per superare questo limite, con riguardo al problema della residenza anagrafica dei ‘senza fissa dimora’ e, conseguentemente al problema del loro diritto alla salute, occorre fare riferimento a quanto prevede il nostro ordinamento:
- il comma 3 dell’Art. 1 della legge n. 1228/1954 come sostituito dal comma 38 dell’art. 3 della legge n. 94 del 15 luglio 2009 recita «…la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all’ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita».
Il Ministero dell’Interno, con la Circolare n. 19 del 7 settembre 2009, ha poi chiarito che il comma 38 della legge n. 94 del 2009 deve essere interpretato nel senso che le persone senza fissa dimora, iscritte all’anagrafe presso un domicilio, devono essere reperibili ai fini dell’accertamento.
- la Circolare ISTAT n. 29 del 1992 ha previsto una via fittizia in base alla quale ogni Ufficio Anagrafe deve registrare la persona senza tetto o senza dimora nel registro della popolazione residente, istituendo la residenza in una via fittizia che non esiste dal punto di vista territoriale/toponomastico ma ha equivalente valore giuridico e nella quale la persona elegge il proprio recapito.
L’istituzione della residenza nella via fittizia rappresenta un importante strumento con il quale dare riconoscimento anagrafico alle persone senza fissa dimora e il diritto a ricevere la posta o gli atti ufficiali, come una tessera sanitaria; agevolare l’identificazione della persona e della sua storia sociale.
È bene precisare che l’iscrizione nella via fittizia o territorialmente non esistente costituisce residenza anagrafica a tutti gli effetti e permette il rilascio della carta di identità, nonché l’accesso a tutti i diritti e le prestazioni normalmente dipendenti dall’iscrizione anagrafica (diritti civili, diritti sociali, diritto alla salute e alla cura di sé). Occorre, tuttavia, considerare che l’iscrizione presso una via fittizia spesso risulta burocraticamente difficile perché richiede colloqui preliminari con i servizi sociali e ha tempi di gestione molto lunghi (per approfondimenti consultare la nostra ricerca “Senza tetto non senza diritti”).
Una svolta importante in questa materia è arrivata il 22 luglio 2021 dalla Regione Emilia-Romagna, con l’approvazione di un progetto di legge, proposto dal Presidente di Avvocato di strada Antonio Mumolo, che consente alle persone senza fissa dimora di avvalersi del medico di base, anche se sprovvisti di residenza sul territorio regionale. Grazie a questa legge anche le persone senza dimora possono vedere riconosciuto concretamente il loro diritto alla salute, iscrivendosi presso le liste Ulss. In questo modo si riducono le disuguaglianze e si afferma che il diritto alla salute non è subordinato al censo.
L’Emilia-Romagna si presenta come apripista di un modello sanitario inclusivo e solidale, al momento imitato anche da altre Regioni (per approfondire consulta la sezione in alto “Le normative regionali”), che si spera sia seguito in tutto il territorio nazionale, affinché si possa arrivare a ribadire ciò che dovrebbe essere un’ovvietà: se un diritto non vale per tutti, non è un diritto, è un privilegio.
Al fine del riconoscimento del diritto all’assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora e prive della residenza anagrafica sul territorio nazionale, con l’intento di superare tutte le problematiche fin qui illustrate, su impulso di Antonio Mumolo, il 4 aprile 2023 hanno preso il via i lavori in Commissione Affari sociali alla Camera sulla proposta di legge a prima firma di Marco Furfaro (PD).
Il principale obiettivo di questa proposta è la modifica del comma 3 dell’art. 19 della legge n. 833 del 1978 per effetto della quale tali persone avranno diritto ad iscriversi negli elenchi relativi al territorio regionale in cui si trovano.
Come fin qui precisato, la residenza anagrafica (o l’iscrizione anagrafica) è il requisito fondamentale per l’esercizio del diritto alla salute e per l’accesso al SSN. Pertanto, la residenza anagrafica è un diritto soggettivo non solo dei cittadini italiani ma anche degli stranieri comunitari ed extracomunitari regolarmente soggiornanti nel nostro Paese (con permesso di soggiorno), con la conseguenza che ne rimangono esclusi coloro che non hanno un titolo di soggiorno valido. Essere stranieri non è certo una condizione privilegiata, ma se a tale condizione si aggiunge anche quella di non avere una dimora abituale, e, quindi, una residenza, allora la situazione si fa davvero critica, soprattutto con riguardo al diritto alla salute.
Anche per i ‘senza dimora’ stranieri, come per i cittadini italiani (v. supra) l’impasse è superabile con l’iscrizione anagrafica presso una via fittizia che, come è stato stabilito dalla sentenza n. 11044/2022 della Terza Sezione del Consiglio di Stato, non è ostativa al rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno e garantisce anche il diritto alla salute.
Su diritto alla salute dei ‘senza dimora’ assume fondamentale importanza anche l’Accordo tra Stato e Regioni del 20 dicembre 2012 sottoscritto, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo n. 281 del 28 agosto 1997, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, contenente «Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome». Per ulteriori approfondimenti sul tema consigliamo questa lettura.
In generale, la tutela della salute è materia di competenza concorrente tra Stato e Regioni, ma per supportare le Regioni, nel 2008 è stato istituito il Tavolo tecnico interregionale “Immigrati e Servizi sanitari” che ha prodotto un documento successivamente approvato dalla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e recepito nel sopradetto Accordo Stato Regioni.
In base a tale Accordo:
- gli stranieri non appartenenti all’UE con regolare permesso di soggiorno hanno obbligo o la facoltà (a seconda della tipologia di permesso di soggiorno) di iscriversi all’SSN previa presentazione di alcuni documenti (quali, il certificato di residenza o la dichiarazione di effettiva dimora);
- gli stranieri senza regolare permesso di soggiorno o Stranieri Temporaneamente Presenti (STP) non possono iscriversi all’SSN ma accedono alle cure ambulatoriali urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia e infortunio, oltre che ai programmi di medicina preventiva, attraverso il rilascio di un tesserino con un codice individuale STP dietro sottoscrizione, da parte del cittadino non comunitario, di una dichiarazione di indigenza. Al momento del rilascio del tesserino, vengono registrate alcune informazioni (come cognome, nome, sesso, data di nascita, nazionalità, recapito). Qualora non fosse possibile esibire un documento d’identità, è necessario rilasciare una dichiarazione delle proprie generalità. I dati relativi agli stranieri temporaneamente presenti sono riservati, così come previsto dalla vigente normativa sulla tutela dei dati personali. Le prestazioni sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa (ticket), ad esclusione dei casi di esenzione. Il tesserino STP è valido per 6 mesi dal rilascio, rinnovabile, su tutto il territorio italiano;
- gli stranieri appartenenti all’UE, se hanno diritto all’iscrizione al SSN, possono presentare autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora; inoltre, è anche possibile procedere all’iscrizione volontaria qualora vi sia un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi;
- gli stranieri appartenenti all’UE senza Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), senza attestazione di diritto di soggiorno, senza requisiti per l’iscrizione al SSN, accedono alle prestazioni sanitarie urgenti o essenziali, ancorché continuative, per malattia e infortunio, oltre che ai programmi di medicina preventiva, attraverso il rilascio di un tesserino con il codice individuale Europeo Non Iscrivibile (ENI). Grazie a tale tesserino è garantito l’accesso alle prestazioni sanitarie ai cittadini comunitari in condizione di fragilità sociale e in stato di indigenza, non residenti in Italia, privi di copertura assicurativa nel proprio paese e non iscrivibili al SSN. Le prestazioni sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa (ticket), ad esclusione dei casi di esenzione. Il tesserino ENI è valido per 6 mesi dal rilascio, rinnovabile, a livello regionale.
Grazie a tali tesserini ENI e STP è possibile accedere alle cure urgenti ed essenziali, anche se non danno accesso al medico di medicina generale, per cui le strutture di riferimento rimarranno, per queste persone, gli ambulatori ad accesso diretto.
Fatte queste necessarie premesse, si precisa che l’Accordo tra Stato e Regioni 2012 ha previsto anche alcune innovazioni dedicate agli stranieri comunitari ed extracomunitari senza fissa dimora, sia per quanto riguarda gli STP (gli stranieri senza regolare permesso di soggiorno o Stranieri Temporaneamente Presenti) sia per gli ENI (cittadini europei Non Iscrivibili):
- inserimento del codice X01 per l’esenzione dal pagamento del ticket per gli stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale in condizioni di grave indigenza. Tra le prestazioni essenziali da garantire a tutte le persone, insieme a quelle urgenti, rientra anche l’assistenza farmaceutica;
- garantire agli STP le cure essenziali atte ad assicurare il ciclo terapeutico e riabilitativo completo per la possibile risoluzione dell’evento morboso, compresi anche eventuali trapianti;
- rilascio preventivo del tesserino STP, per facilitare l’accesso alle cure;
- equiparare i livelli assistenziali ed organizzativi del tesserino STP al tesserino ENI;
- proporre l’estensione del tesserino ENI nelle regioni/province che non lo hanno ancora previsto.
Infine, in base all’Accordo tra Stato e Regioni 2012, se il cittadino straniero è un richiedente di protezione internazionale, si fa riferimento all’autocertificazione di effettiva dimora o alla dichiarazione di ospitalità. L’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) provvede a consegnare ai cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari senza fissa dimora i tesserini ENI e STP.
L’obiettivo dell’Accordo era garantire una maggiore uniformità dei percorsi di accesso all’assistenza sanitaria per la popolazione straniera in Italia ma purtroppo, a distanza di quasi undici anni, si rileva un quadro frammentato di applicazione dell’Accordo medesimo sul territorio nazionale.
In attesa dell’emanazione di una legge nazionale, si segnala che attualmente solo alcune Regioni hanno adottato iniziative in tal senso. Secondo l’ordine cronologico degli interventi, queste Regioni sono l’Emilia-Romagna, la Puglia, la Calabria, il Piemonte, la Lombardia, l’Abruzzo e la Liguria.
La prima Regione è stata l’Emilia-Romagna con la legge regionale n. 10 del 29 luglio 2021, presentata dal Presidente di Avvocato di strada, Antonio Mumolo, nella veste di Consigliere Regionale. L’oggetto e le finalità del provvedimento sono ben esplicitati nell’articolo 1 che recita «Al fine di assicurare l’esercizio del diritto all’assistenza sanitaria, la Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della propria potestà di organizzazione del Servizio sanitario regionale, riconosce ai cittadini italiani senza dimora e non residenti in paesi diversi dall’Italia, privi di qualsiasi assistenza sanitaria, la possibilità di iscriversi nelle liste degli assistiti delle aziende USL del territorio regionale, e di effettuare la scelta del Medico di Medicina Generale (MMG o medico di famiglia), nonché di accedere alle prestazioni garantite dai LEA per i cittadini italiani residenti in Italia».
La scelta del medico di medicina generale ha validità annuale, a condizione che il cittadino permanga sul territorio regionale e venga attestata attraverso il rilascio di un promemoria di iscrizione del Servizio sanitario regionale da parte dell’anagrafe sanitaria.
La legge regionale dell’Emilia-Romagna ha previsto che siano i Servizi sociali ad accertare la condizione di senza fissa dimora della persona e a rilasciare l’apposita attestazione, anche attraverso la collaborazione con i soggetti del Terzo settore che svolgono attività in favore delle persone in situazione di fragilità. Sempre il Servizio sociale deve provvedere all’identificazione della persona e all’avvio degli adempimenti necessari per la scelta del medico di base. Per approfondimenti sulla questione dei senza fissa dimora e del medico di base è possibile consultare questa pagina.
Il 30 novembre 2021 anche la Puglia ha approvato la legge regionale n. 44, il cui Art. 1 dal titolo “Oggetto e finalità” stabilisce che «1. Per assicurare l’esercizio del diritto all’assistenza sanitaria, la Regione Puglia, nell’ambito della propria potestà di organizzazione del Servizio sanitario regionale, riconosce alle persone senza dimora, di cui all’articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente), il diritto di iscriversi nelle liste degli assistiti delle Aziende sanitarie locali (ASL) del territorio regionale, a seguito di segnalazione da parte dei servizi sociali pubblici, e di usufruire dell’assistenza sanitaria primaria. 2. La Giunta regionale, per le finalità di cui al comma 1, può altresì individuare condizioni di maggior favore per garantire l’assistenza medica di base delle persone senza dimora. 3. La Regione si conforma a eventuali normative nazionali qualora determinino, nella materia di cui ai commi 1 e 2, ulteriori condizioni migliorative per le persone senza dimora».
Il 17 marzo 2022 la Regione Calabria ha presentato una proposta di legge sull’Assistenza sanitaria di base per i senza fissa dimora affinché abbiano diritto all’assistenza di un medico di famiglia.
In Piemonte, a Torino, il 2 maggio 2022 è stato sottoscritto il Protocollo di intesa tra la Prefettura di Torino, la Regione Piemonte, il Comune di Torino, la Città Metropolitana di Torino, l’Azienda Sanitaria Locale Città di Torino, le Arcidiocesi di Torino, le Circoscrizioni del Comune di Torino e la Federazione Italiana Organismi Persone Senza Dimora, avente ad oggetto il Piano integrato di sostegno alle persone senza dimora. Anche questo intervento, come quello della Regione Emilia-Romagna, si basa principalmente sulla cooperazione tra la sfera pubblica e il Terzo settore.
Il 16 maggio 2022 la Regione Lombardia con la delibera N° XI/ 6371 ha pubblicato il nuovo Piano triennale regionale dei servizi per il contrasto alla povertà 2021-2023, in attuazione del Decreto del 30 dicembre 2021 con cui è stato approvato il Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà e il riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale’ relativo al triennio 2021-2023. Gli interventi e i servizi previsti dal Piano in favore delle persone in condizione di povertà estrema e senza fissa dimora sono i seguenti:
- rendere effettivo il servizio di iscrizione anagrafica, garantendo così un domicilio in ogni Comune alle persone senza fissa dimora anche se prive di alloggio;
- implementare i Centri Servizi per il contrasto alla povertà affinché garantiscano alcuni importanti servizi (ad esempio, le mense) che dovranno essere erogati direttamente dai servizi pubblici, o da enti del Terzo Settore, o del volontariato;
- Housing First (‘la casa prima di tutto’), ovvero risorse provenienti da Fondo Povertà e PNRR (Missioni 5 e 6 riguardanti, rispettivamente, inclusione e coesione sociale e salute) destinate a realizzare 250 nuovi progetti sulla base del modello già concordato in Conferenza Unificata;
- elaborare gli interventi di sostegno materiale prioritari per il contrasto alla povertà e alla marginalità, finanziati da diverse risorse escluse quelle del Fondo Povertà.
Il 50% delle risorse del Fondo povertà sono riservate alla programmazione di interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza fissa dimora, individuati dai territori sulla base delle esigenze rilevate.
Il 17 marzo 2023 il Consiglio regionale dell’Abruzzo, ha approvato la legge regionale n. 14 con la quale è stato previsto l’Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie Locali della Regione. L’art. 1 di tale legge recita:
“1. La Regione Abruzzo, al fine di assicurare l’esercizio del diritto all’assistenza sanitaria, nell’ambito della propria potestà di organizzazione del servizio sanitario regionale, riconosce ai cittadini italiani senza dimora e non residenti in paesi diversi dall’Italia, privi di qualsiasi assistenza sanitaria, la possibilità di iscriversi nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) del territorio regionale e di effettuare la scelta del Medico di Medicina Generale (MMG o medico di famiglia), nonché’ di accedere alle prestazioni garantite dai LEA per i cittadini italiani residenti in Italia. 2. L’iscrizione nelle liste degli assistiti delle ASL e la scelta del Medico di Medicina Generale avvengono a seguito di segnalazione da parte dei servizi sociali, secondo le modalità e le procedure definite con atto della Giunta regionale, da approvare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge”.
Il 3 aprile 2023 il Consiglio regionale della Liguria ha approvato all’unanimità una proposta di legge che istituisce l’assistenza sanitaria di base per i senza fissa dimora, prevedendo per loro un medico di base/di famiglia dando così maggiore dignità ai senza fissa dimora. La Regione si impegna, quindi, a garantire l’assistenza sanitaria di base anche alle persone senza fissa dimora, che fino a oggi – in assenza di una residenza – potevano accedere solo al pronto soccorso.
- Corte cost., sentenza n. 112 del 1975, con la quale viene affermato il carattere programmatico dell’art. 32 Cost.;
- Corte cost., sentenza n.103 del 1977, importante nell’affermare il diritto alle cure, alla scelta del medico e del luogo di cura e il diritto a rifiutare le stesse;
- Corte cost., sentenza n.88 del 1979, riguardo la possibilità di operare anche nei rapporti tra privati cittadini. Con tale pronuncia si ebbe l’inequivocabile riconoscimento del diritto alla salute come un “diritto primario ed assoluto da ricomprendere tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione”, ribadito e precisato dalla sentenza Corte cost. 1986 n.184 in tema di danno biologico. Nella sentenza la risarcibilità deriva da una violazione della primaria norma desunta dal combinato disposto degli artt. 32 Cost. e 2043 c.c. e dalla presunta lesione del bene giuridico salute;
- Corte cost., sentenza n.173 del 1987, viene riconosciuto il diritto a ricevere cure gratuite nelle strutture pubbliche ed in quelle private convenzionate con diritto al rimborso da parte del SSN;
- Corte cost., sentenza n.455 del 1990, ha portato il diritto alla salute ad esser definito quale diritto “finanziariamente condizionato”. Il legislatore nel destinare risorse e mezzi per il settore sanitario, è tenuto ad operare un bilanciamento con altri interessi protetti dalla Costituzione. Altro limite, è il rispetto dignità della persona dato che, le esigenze finanziarie, non possono comprimere “il nucleo essenziale del diritto connesso alla dignità della persona”;
- Corte cost., sentenza n.252 del 2001, in tema di titolarità del diritto alla salute, sottolinea la necessità, anche nei confronti dello straniero, di garantire il rispetto dei diritti fondamentali facendo leva sul dato testuale dell’art.32, il quale espressamente parla di “individuo” e non di “cittadino italiano”;
- Corte cost., sentenza n.233 del 2003, con tale pronuncia la Corte si è preoccupata di definire non solo il cosiddetto danno “esistenziale”, ma ha fornito una definizione di “danno morale soggettivo”, come turbamento dello stato d’animo della vittima; per finire con la definizione del “danno biologico”, il quale è considerato quale lesione dell’interesse all’integrità psichica e fisica della persona.
- A. De Cupis, Integrità fisica, in Enc. Giur., XVII, Roma, 1989;
- A. Simoncini, E. Longo, in Commentario alla Costituzione, Rapporti etico-sociali, art.32, R. Bifulco , A. Celotto M. Olivetti (a cura di), Torino, 2006;
- D. Morana, La salute come diritto costituzionale. Lezioni, Seconda edizione, Torino, Giappichelli, 2013;
- R. Balduzzi, G. Carpani (a cura di), Manuale di diritto sanitario, il Mulino, 2013;
- S. Barbareschi, Tecniche argomentative della Corte Costituzionale e tutela dei diritti sociali condizionati. Riflessioni a partire dal diritto alla salute, in federalismi.it, fasc. n. 13, 2018.
- Leggi l’articolo “L’art. 32 della Costituzione”;
- Leggi l’articolo di approfondimento: “Perché è importante parlare di diritto alla salute?”;
- Leggi l’articolo di approfondimento “Novità legislative in materia di assistenza sanitaria alle persone senza dimora”;
- Leggi l’articolo di approfondimento: “La valorizzazione del diritto alla salute nella nuova protezione speciale”;
- Leggi l’articolo “Il diritto alla salute nella giurisprudenza della Corte Costituzionale” ;
- Guarda il WEBINAR “il diritto alla salute, quella di tutti”, organizzato da Avvocato di strada Torino con la partecipazione della dott.ssa Galmozzi;
- Approfondimento sul tema delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) e il consenso informato.

Dott. Bruno Andrea Mamone
Volontario di Avvocato di strada, sede di Varese

Dott.ssa Miriam Pastoressa
Volontaria Avvocato di strada, sede di Foggia

Dott.ssa Carlotta Gregori
Volontaria Avvocato di strada, sede di Bologna
Aggiornata al 1° luglio 2023